Per gli antichi Greci era il numero divino: allorquando filosofia e scienza, in un’unione inscindibile, dipingevano il creato attraverso le sfumature del pensiero, in un connubio sostanzialmente non solo indivisibile ma inevitabilmente interdipendente, seicento anni prima di Cristo, nei territori della Magna Grecia, i pitagorici, il cui apporto qualitativo all’analisi del mondo coniugava musica, matematica, cabala, in un concetto di più ampio approdo filosofico, erano soliti non sfuggire all’idea, vibrante, di un numero che coniugasse e spiegasse l’Universo, il 10.
Un numero-religione, retto dalla tetractys, la “quaternità”, la sacra tetrade, il numero divino frutto della solenne somma dell’uno, del due, del tre e del quattro.
Il numero è bellezza, sottolineavano, armonia, ed armonia ed ordine sono inseparabili.
Il numero è creazione, e, va da sé, il 10 è la creazione.
Difficile supporre che i seguaci di Pitagora, o il sommo stesso, fossero appassionati di calcio, considerando i quasi tremila anni che li avrebbero separati dall’avvento del football.
Eppure, quella magia di cui il numero dieci era rivestito da una delle correnti intellettuali più influenti della storia dell’umanità, sembrava essere modulata, nell’essenza, quasi formulata, delineata, avrebbe trovato apoteosi pagana in quella che sarebbe diventata l’attività ludica ed atletica, sociale e politica più diffusa al mondo.
Il calcio nasce senza numeri, in una geometria del suolo a stento riconoscibile, con lunghezza e larghezza variabili, sui terreni più disparati, con confini mal definiti ed irrazionale assenza dell’altezza: le porte, infatti, teoria conclusiva dell’idea, si estendevano al cielo osservato dai filosofi sorrette soltanto dall’arbitraria sentenza di un pallone che le avesse oltrepassate o meno.
Quando i numeri fecero capolino nella religione del football, il 10, nonostante l’intrinseca, visiva ed essenziale, idea di perfezione della totalità, poco sublimava l’idea dell’investitura che differentemente avvenne attorno alla metà del secolo scorso: durante i Mondiali del 1958, all’alba della modernità contemporanea, le maglie del Brasile allora ancora mai iridato, vennero assegnate casualmente, o quasi.
La 10 finì sulle spalle di un non ancora diciottenne Edson Arantes do Nascimento, ed il 10 esplose di sublimazione pitagorica, entrando nell’immaginario collettivo come il numero per eccellenza, identificativo dell’interprete migliore, di chi, con lo strumento del calcio, era solito sciorinare una qualità impareggiabile, “la” bellezza, l’armonia e la genialità del pensiero.
La dittatura meritocratica del numero 10, la sensazione che il calcio avesse in quell’espressione la sua più assoluta sublimazione, la sua versione più pittoresca ed artistica, determinò un’idea di gioco che potesse sorreggersi in ultima istanza “sull’invenzione” , sulla giocata determinante, sull’intuito , sull’idea, sulla conclusione tecnico-balistica, sulla visionaria creazione di spazio e di tempo del numero 10, volta a sovvertire andamenti, ad eludere schieramenti, ad umiliare marcature “a uomo”.
Così, in maniera strettamente dipendente alle diverse culture permeanti i singoli territori del pianeta e alle conseguenti e correlate idee calcistiche, il 10 ha da sempre rappresentato la variabile decisiva del gioco del calcio, la fantasiosa rappresentazione del genio che, per dirla alla Nietzsche, è al di là del bene e del male.
Il calcio sudamericano, rispetto al più tatticamente evoluto e fisicamente dominante europeo, ha immediatamente ceduto lo scettro della propria rappresentazione al numero 10: il Brasile del 1970, per molti la migliore squadra di ogni epoca, non lesinava di schierare, con O’rey, quanta più qualità possibile, sovrapponendo, nella creazione, la contemporanea presenza di più elementi che avrebbero potuto singolarmente indossare il numero magico; da contraltare, la nostra Italia, si trucidava del ballottaggio fra Rivera e Mazzola.
Indipendentemente dalle differenti inclinazioni emotive, antropologiche, culturali e caratteriali che concorrevano a determinare l’impiego dei numeri 10 nell’evoluzione della storia calcistica di ogni singolo paese, nessuna squadra, nel panorama mondiale, osava mettere in discussione la presenza di almeno un uomo che possedesse quella qualità da esprimere preferibilmente nella zona nevralgica della metà campo avversaria, del “trequartista” capace di inventare corridoi attraverso i quali sciorinare assist , del giocatore capace di creare superiorità numerica, di costringere l’avversario al fallo sistematico con conseguente possibilità di ricorrere in ammende determinanti per l’andamento dell’incontro, del calciatore dalle qualità tecniche indiscutibili capace di dettare i ritmi di gioco, di facilitare i tempi della manovra e, dulcis in fundo, di sublimare la bellezza nella sua accezione più pura, platonica, la bellezza che crea felicità, che rende il calcio arte.
La maglia numero 10 è semplicemente l’anima nascosta del calcio: che riecheggiasse Meazza o Valentino Mazzola, Puskas e la grande Ungheria degli anni cinquanta incomprensibilmente non iridata ( e tatticamente evolutissima, tanto da schierare il primo “falso nove” della storia, Hidegkuti ), Liedholm o Sivori ( “Maradona prima di Maradona”), Luisito Suarez e Rivera, che sintetizzasse la “totalità” del calcio olandese rappresentato simbolicamente dal genio di Cruijff, che fosse nobilitata da Antognoni, Zico, Platini, Roberto Baggio, fino all’apoteosi Diego, è stata indiscutibilmente la maglia più decisiva della storia del football.
Ciò anche perché, eccezion fatta per alcune espressioni più peculiari precedentemente citate, il calcio, comprensibilmente nella sottile diversità di interpretazioni e posizionamenti, ha constato, sino allo spartiacque rappresentato da Arrigo Sacchi, di un’identificazione ben definita di ruoli, mansioni, zone di campo da occupare, e, similarmente, di concetti sostanzialmente riconducibili a principi basilari universalmente riconosciuti:terzini, libero, stopper, metodista o regista coadiuvato da un incontrista, ala destra ( o tornante ) e sinistra ( a volte nella più offensiva investitura di seconda punta), numero 10 e prima punta. …….
Nello sviluppo delle due fasi di gioco, ovviamente influenzate nella qualità della manovra dalla circolazione del pallone, dalla ricerca dei tempi di gioco volti ad una più precisa e proficua occupazione degli spazi esaltata dai movimenti senza palla forieri della creazione di indispensabili linee di passaggio, in un calcio non “sanzionato puntualmente” dal fuorigioco, il numero 10, sin anche all’evoluzione più fisica idealmente rappresentata agli albori da profili quali Ruud Gullit e Lothar Matthaus, sanciva la qualitativa riuscita del vocabolario calcistico del collettivo.
Arrigo da Fusignano, nella primavera della Fiorentina prima, nel Rimini , nel Parma e nel Milan poi, si preoccupa di rivoluzionare concezioni e ridisegnare il modo di sciorinare calcio: una vera e propria linea di demarcazione col football precedente che sì aveva conosciuto filosofie straordinarie ( su tutte l’interpretazione carioca e la corale irrequietezza della totalità olandese), ma mai si era imbattuto in dinamiche così innovative che abbracciavano linee, armonia, reparti all’unisono, copertura del campo specifica e correlata funzionalmente a precisi movimenti, pressing e “riduzione” del terreno di gioco .
E, fra tutte, la zona, la ricerca sistematica del fuorigioco, che ha sostanzialmente comportato la scomparsa del libero vecchio stampo, il cui compito di regista difensivo , le letture da ultimo uomo quale guardaspalle dei marcatori, si trasformano in un gioco di linea e di reparto col resto dei componenti della difesa.
C’è un prima e un dopo Sacchi: anche per il numero dieci? La mente, dopo questa domanda, corre naturalmente alla spiazzante sostituzione di Roby Baggio contro la Norvegia successivamente all’espulsione di Pagliuca, a onor del vero giustificata dalle torride temperature e dal pensiero delle gare successive.
Oggi, in inferiorita’ numerica, in molti preferiscono non sostituire il proprio “dieci” : allora erano altri tempi!
Non che Sacchi abbia volontariamente contribuito a distruggere l’espressione per antonomasia del giocatore per eccellenza dello schieramento calcistico, contribuendo a riciclare i trequartisti da seconde punte o diligenti esterni di centrocampo, ma, inevitabilmente, i nuovi concetti di cui il tecnico emiliano è stato precursore hanno disgiunto il concetto di un numero dieci classico.
L’avvento della fisicità quale discriminante decisiva della modernità, ritmi sempre più incalzanti e sfruttamento dell’ampiezza che non fosse più soltanto la ricerca del fondo da parte principalmente dei terzini di spinta o delle ali, la necessità di costruire profili che abbinassero le doti atletiche della corsa e della velocità alle capacità tecniche di conduzione e gestione, hanno determinato la scomparsa del numero dieci secolarmente inteso: così la trequarti è divenuta territorio di competenza di centrocampisti bravi nell’inserimento e con spiccate qualità tattiche, di registi “avanzati” ( Zidane sublime ed irraggiungibile espressione), di seconde punte capaci di giocare fra le linee per cucire una manovra sempre più dinamica ed avvolgente.
In sostanza, la modernità ha involontariamente “ucciso”, sin dalla rivedibile formazione giovanile, il profilo del dieci classico: i giocatori di qualità, nell’ultimo quindicennio, sono stati via via sempre più identificati con gli esterni alti capaci, in alcuni casi, non già di “dribblare” ( un gesto tecnicamente sempre più raro) ma di “superare atleticamente” l’avversario diretto .
Non è un caso che il dieci per eccellenza dell’ultima era, Messi, sia quasi sempre partito da una posizione defilata per poi rientrare ed occupare le zone di campo più prettamente consone al giocatore di qualità.
Non che gli esterni siano “invenzione” delle ultime due decadi; senza scomodare Best o Garrincha, Bruno Conti o Dragan Dzajic, Gento o Czibor fino al primo pallone d’oro Stanley Matthews, le “ali” hanno caratterizzato l’epoca moderna quando ancora la concomitanza con il dieci classico era sottintesa: da Luis Figo a Ryan Giggs, da Overmars a Pavel Nedved, da Mc Manaman a Beckham, da Donadoni a Robben, tante sono state le stelle del calcio padroni delle corsie laterali.
La prerogativa del ruolo è però cambiata, risucchiando il numero dieci: non più saltare l’uomo e crossare palloni al servizio degli attaccanti ( come in epoca pre-televisiva con il “metodo” o il “sistema” ), motivo per il quale quasi mai si giocava a piedi invertiti diminuendo la possibilità di servire le punte in area attraverso i traversoni, ma puntare il diretto avversario, accentrarsi e concludere a rete.
Così, anche talenti tecnicamente e per caratteristiche puramente riconducibili al dieci classico, come Neymar, hanno esposto la propria carriera alla moderna interpretazione del ruolo.
Vero è, rispetto al passato, che la responsabilità con la palla è giunta fino ai difensori e ai portieri, alla ricerca di un modello che conceda molto meno al destino e progressivamente di più all’organizzazione: possesso, sviluppo e rifinitura non competono più ad elementi indiscutibilmente prescelti che prima semplificavano da sé ogni situazione di gioco con un dribbling, un cambio di campo o una elementare ( ma non troppo) sponda.
Il numero dieci classico si è estinto perché la sua essenza non era solo occupare le zone fra le linee per ricevere palla ma seguirne il richiamo, cercarla, addomesticarla, coccolarla, tradurla; oggi la palla deve correre senza dare il tempo all’avversario di coprire la distanza, i giocatori di qualità devono offrire l’appoggio non andando incontro al pallone bensì smarcandosi alle spalle della linea avversaria, quasi che allontanarsi dal pallone significhi avvicinarsi al gioco, eresia concettuale per la storia del numero magico.
Non più un ruolo che incarni bellezza, vizi e virtù, fantasie dell’essere umano, lontano dall’esplosività e volto a muoversi nella terra di nessuno, se non sua, poiché presente.
Non più un ruolo.



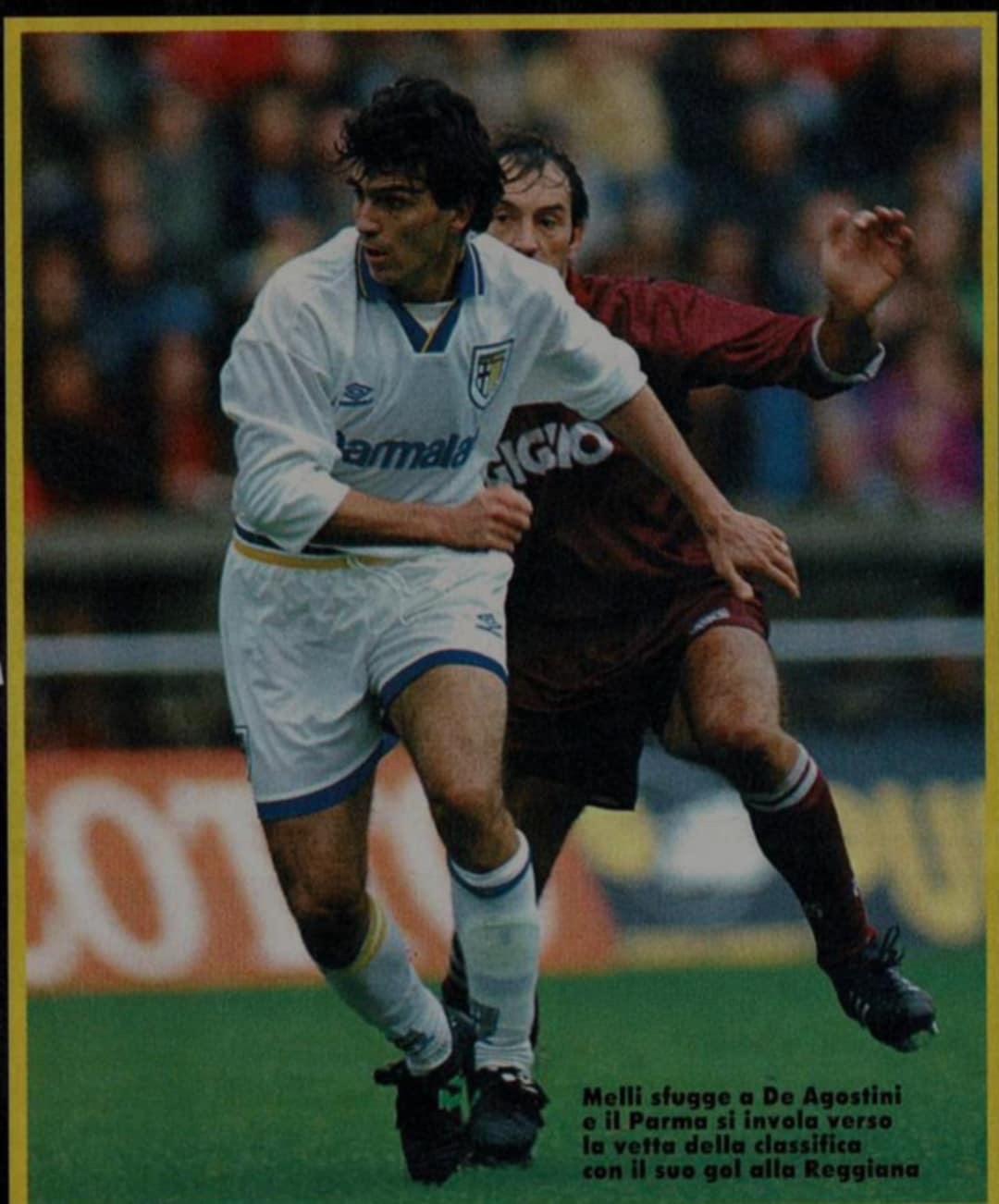












5 risposte
Io un po’ di nostalgia dei 10 c’è l’ho….
Complimenti per il racconto
Andrea, intanto mi complimento, per la tua prosa. Mi è piaciuto anche il racconto storico e la logica dell’evoluzione del ruolo del 10.
Concordo abbastanza con quanto da te esposto. Andando con la mente dalla mia adolescenza in poi, ricordo che negli anni 50 (dal ’55 ho iniziato ad interessarmi di calcio) e o guardando la Serie D della mia cittadina o le sintesi della domenica sera della Serie A, ricordo che nelle azioni di attacco erano le ali ad essere determinanti. forse anche più di adesso. Erano tutti dribblatori, mentre oggi, si tende a saltare l’uomo con la catena di fascia.
Ovviamente, ero un ragazzo senza formazione tattica, ma Hamrin, Selmonsson, Skoklund, Julinho, Ghiggia, Danova, il mio amato Garrincha (da te già citato) erano molto decisivi. Ma sono solo sottigliezze, dovute al mio vissuto rispetto ai tuoi studi.
Quanto all’evoluzione del “10” hai ragione, credo che l’ultimo grande 10, almeno a livello italiano, sia stato Totti. IL “pezzo” che più m piaceva era lo smistare, in corridoio, di prima, spalle alla porta, la palla per il suo compagno, oltre ovviamente alle altre grandi caratteristiche “fronte alla porta”.
Se, poi, con il 10 intendiamo il campione che fa la differenza, non credo che il ruolo si sia estinto, certo modificato e forse evoluto nella logica della frenesia del modo di giocare di oggi. Ma il Messi dell’ultimo mondiale, il Dybala della Roma, sono ancora decisivi anche in questo calcio.
Ma è innegabile, ad oggi, quanto dici tu, sulla rarefazione del tipo di giocatore da te descritto.
Per chiudere vorrei solo segnalare il mio dieci preferito di sempre che è stato Rivera e non sono milanista. Oltre che efficace era anche elegante.
Complimenti, testo bellissimo.
Da leggere e far leggere…
Per chi sa leggere!
Applausi all’autore.
Chapeau per il pezzo!!!
Esempio di cultura e conoscenza calcistica.