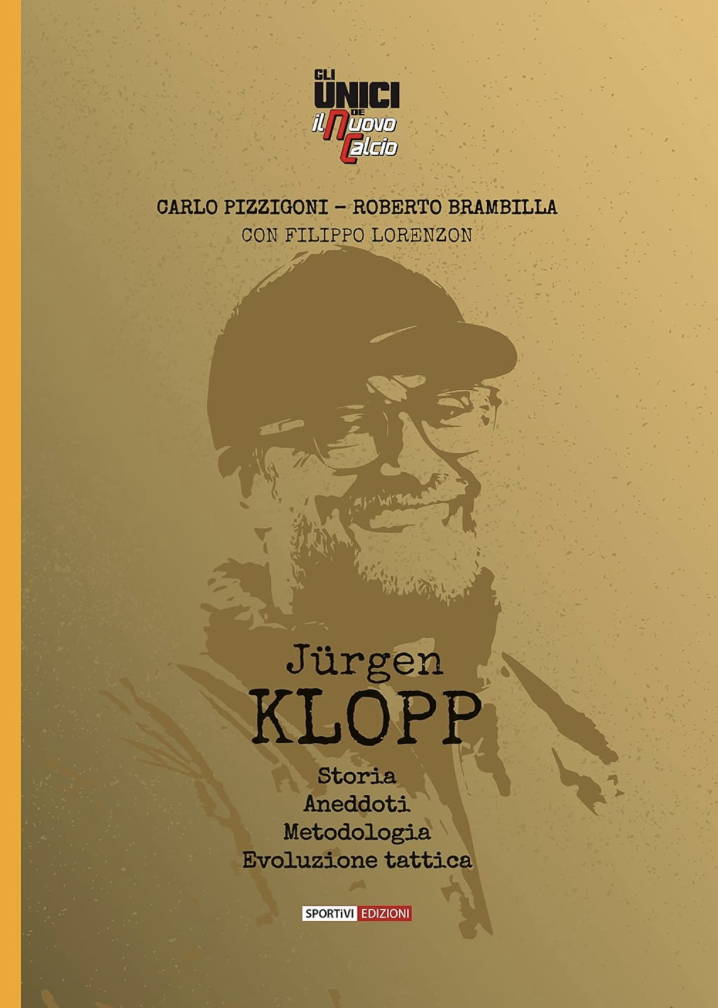Partiamo dal libro scritto da Carlo Pizzigoni e Roberto Brambilla, con Filippo Lorenzon: “Jürgen Klopp – storia, aneddoti, metodologia, evoluzione tecnica”.
Carlo Pizzigoni presenta la monografia su Klopp, citando Fassbinder e Rossellini – ed entrambi hanno a che fare con la vita perché raccontano delle storie. L’uomo, fin dall’antichità e dai racconti tramandati per via orale, se ne nutre. Alcune sono storie di campo, di trionfi o di disfatte; storie nebulose, in senso non solo metaforico, come quelle che, per uno scherzo del destino, sembrano accomunare Arrigo Sacchi con Johan Cruijff.
Da una parte la nebbia provvidenziale di Belgrado, annunciata dal prodromo raggelante delle raffiche di mitraglietta, sparate dalle cosiddette Tigri, i paramilitari serbi al seguito del comandante Arkan.
Dall’altra, la coltre dell’Olimpico di Amsterdam, dalla quale emerse, quasi come un presagio divino, la luce folgorante dell’Ajax di Rinus Michels, che avrebbe dominato per anni in Europa e che, quel 7 dicembre del 1966, impartì una lezione al grande Liverpool di Shankly, pur potendo contare su due soli giocatori professionisti in rosa. Uno, Piet Keizer, fu dichiarato indisponibile all’ultimo momento perché infortunatosi in ritiro durante una partitella a ping pong (sic); l’altro si chiamava, appunto, Johan Cruijff, colui che, afferma Cantona, «se avesse voluto, avrebbe potuto essere il miglior giocatore in ogni posizione del campo.» Di questa storia e di molte altre si parla in La mia rivoluzione – Johan Cruyff, con prefazione di Carlo Pizzigoni e Federico Buffa.
Storie di provincia – Fusignano, il villaggio di cemento, ossia Betondorp, città natale di Cruijff e la Foresta Nera di Jürgen Klopp – suggellate dal caso e dalla sorte, come se fossero state vergate dalla penna, cinica, ma struggente, di Jim Thompson.
Sono storie incredibili, come quella del colombiano Anderson Arroyo, l’eterno viaggiatore del Liverpool, acquistato dalla squadra di Klopp nel 2018 e da quel momento perenne girovago: Maiorca, Gent, Mlada Boleslav, Salamanca, Mirandés, Alavés e infine, dopo un inaspettato rinnovo di contratto, l’Andorra. Non ha mai toccato il prato di Anfield, nemmeno per un istante. La vicenda è suggestiva, nei suoi contorni girovaghi, ma la questione non è necessariamente legata alle qualità del calciatore colombiano (e risulta piuttosto figlia di un tipico arzigogolo burocratico): Arroyo non dispone ancora del permesso di lavoro che gli consentirebbe di giocare in Inghilterra.
Come quella di Scott Carson, terzo portiere del Manchester City. Il minutaggio di Scott nella squadra di Guardiola è a dir poco esiguo: poco più di cento minuti dal 2019. Però sembra una specie di zio simpatico che nessuno vorrebbe mai mandare via. E infatti, all’indomani della finale di Istanbul e nel tripudio generale, gli è stato rinnovato il contratto. Ma Carson ha un’altra particolarità non banale, qualcosa che lo rende più di un semplice calciatore, quasi un amuleto, una storia, appunto, degna di essere narrata: è l’unico giocatore, nella rosa attuale del City, ad aver vinto due Champions League (la prima, sempre a Istanbul, quando giocava con il Liverpool: noi milanisti lo raccontiamo con una punta di dolore). In entrambi i casi, senza mai scendere in campo.
E poi ci sono storie diventate, loro malgrado, leggende, come quella di Luis Silvio Danuello, protagonista di una vicenda che sembra uscita dalle pagine di Osvaldo Soriano, uno dei massimi cantori letterari di questo sport. Nel 1980, poco dopo la riapertura delle frontiere calcistiche, chiuse dalla Federazione nel ’66, la Pistoiese, nuova in A, decise di andare a cercare talenti e fortuna in Brasile. Melani, l’allora presidente della squadra toscana, inviò un osservatore con l’unica raccomandazione che un piccolo club, in vena di fare acquisti, poteva dare: spendere poco, pochissimo, se possibile.
Il resto, con il famigerato fraintendimento tra “punta” e “ponta” (“eu sou uma ponta direita”, un’ala destra, aveva risposto Danuello a chi lo interrogava sul suo ruolo!), pare davvero uscito da quel capolavoro che è Il rigore più lungo del mondo: «– Bene, ragazzo, – mi disse. – Un giorno andrai in giro da queste parti a raccontare che hai segnato un goal al Gato Dìaz, ma nessuno ti crederà.»
Storie, queste, che rischiano di essere relegate ai bordi dalla Storia, come capita al fedelissimo aiutante Norman ne Il servo di scena, di Peter Yates, neppure citato nell’autobiografia di “Sir”.
Quella di Jürgen Klopp è una storia che resterà impressa per sempre nella hall of fame del calcio mondiale, e non soltanto per i successi e per i trofei conquistati in carriera, una carriera cominciata molto presto, intorno ai 34 anni. Se coppe e medaglie fossero l’unico metro di giudizio a disposizione, non celebreremmo allenatori come Zeman o Marcelo Bielsa, personaggi dalla statura omerica: perfetti depositari dell’areté greca, intesa proprio come capacità di assolvere il proprio compito, eppure poco vincenti, per la scelta di lavorare sui margini e non in mezzo alla scena. Parimenti non ci ricorderemmo forse di Wolfgang Frank che di Klopp è stato il principale maestro, quasi una sorta di personale André Bazin per quella Nouvelle Vague calcistica di cui der lange (lo spilungone, come lo chiamavano quando era ragazzo) è stato indiscusso cantore, dapprima al Mainz e in seguito al Borussia Dortmund.
Archiviata o ripensata la figura del libero, certezza granitica del gioco tedesco pre-riforma, si cominciò a ragionare – lo fece, per primo, Ralf Rangnick – sulla cosiddetta “marcatura a zona orientata dalla palla”. Il perfezionamento di questa idea esitava in una frenesia che non voleva naturalmente essere anarchica: servivano interpreti in grado di pensare e agire con rapidità e precisione. Serviva e serve – ormai questo è un po’ una sorta di mantra – tempo. Del resto non si può pensare al Picasso di “Guernica”, senza considerare la base classicissima del pittore di Malaga: si può destrutturare e ricomporre solo dopo aver saputo comprendere la struttura profonda di ciò che c’era in precedenza: una pars destruens a cui segue una pars construens, secondo un metodo baconiano. Rangnick, soprannominato, con malcelato sarcasmo, il professore (fußballprofessor), è una delle voci – tutte invero interessanti, nella loro eterogeneità – che compongono il volume di Pizzigoni e Brambilla. A proposito di Klopp, Rangnick pone l’attenzione su un aspetto che travalica il dato tattico, ma in un certo senso ci aiuta a definirlo meglio, nei suoi connotati relazionali. Dopo averne lodato l’intelligenza – emotiva, aggiungerei, pensando agli assunti di Goleman – e le qualità da leader, dice infatti: «È una persona capace di guidare gli altri in un percorso.» (p. 98)
Sul significato di leadership hanno riflettuto studiosi del calibro di Max Weber, ma nel caso specifico di Klopp, il puzzle sembra essere composto da tasselli molto simili l’uno all’altro, tutti convergenti. Ivan Javorcic, intervistato a proposito del manager del Liverpool, ritiene che sia «la capacità di condurre e migliorare le persone.» (p. 183)
C’è quindi, come riflette Erich Rutemöller, ex responsabile della formazione degli allenatori tedeschi, un aspetto squisitamente calcistico, ma c’è anche molto altro. Frank, scomparso nel 2013 e tuttavia evocato nel saggio grazie alla giornalista Mara Pfeiffer, che sul maestro di Klopp ha scritto una biografia, spinse il giovane Jürgen verso il gegenpressing attraverso lo sviluppo dell’idea di “copertura orientata alla palla” (il libro di Pizzigoni e Brambilla, tra le altre cose, presenta un notevole inserto tattico a cura di Filippo Lorenzon, che consiglio di leggere). Inoltre, lo instradò verso l’utilizzo della difesa a quattro, principio piuttosto pionieristico, in Bundesliga, quando Wolfgang Frank aveva cominciato a praticarlo. Si trattava di un calcio ad altissima intensità e velocità, ma con la raccomandazione di evitare il fallo sull’azione di pressing, in modo da non vanificare lo scopo principe che è sempre quello di recuperare il pallone.
Dunque un gioco fisico, ma mediato dalla testa, cioè in controllo. Proprio la capacità di giocare a la Frank, fu l’innesco fortunato – ma immagino che, presto o tardi, sarebbe accaduto lo stesso – che condusse l’inesperto Klopp sulla panchina del Mainz. Il dirigente, Christian Heidel, per tentare di scampare a una retrocessione che vedeva avvicinarsi inesorabile, decise di esonerare Eckhard Krautzun e si mise alla ricerca, parole sue, di qualcuno che «sapesse mettere in pratica quel modulo e sapesse insegnarlo ai giocatori». (da Scatenate l’inferno, ed. Rizzoli, p. 13). Quel qualcuno era Jürgen Klopp, col piccolo particolare che si trattava di un giocatore della squadra che avrebbe dovuto allenare! Non era neppure il capitano, anche se veniva percepito da molti compagni come tale per il carisma naturale e per l’entusiasmo che sapeva trasmettere. Aveva una laurea in scienze motorie, è vero, ma non possedeva ancora il patentino da allenatore. La sala stampa, si racconta, all’annuncio della nomina, scoppiò in una risata fragorosa, ma il ragazzo della Foresta Nera non si scompose più del necessario: «dovete dirmi voi cosa devo dire», chiosò sornione, come abbiamo poi imparato a conoscerlo.
Ed è questo un lascito non meno fondamentale da parte di Wolfgang Frank: l’abilità di porre i fatti in prospettiva, un’allegria mai sciocca o puerile, la lievità intelligente di chi sa di non essere stato chiamato a salvare il mondo nonché la consapevolezza che non si può vincere, perlomeno non a lungo, senza stabilire rapporti umani proficui. Proprio Frank era solito riportare i dettami tattici del calcio professionistico al gioco dei bambini. Cosa fa un bambino quando vede una palla? Istintivamente, la segue. Ebbene questo era il nucleo: seguire la palla e cercare di averne il possesso, e poi spalancarsi come una mano chiusa a pugno che, all’improvviso, si apre.
Non stupisce che un altro grande stratega come Johan Cruijff, poco prima della finale di Champions League con il Barcellona, abbia raccomandato ai suoi ragazzi di… divertirsi.
Klopp non è stato un giocatore memorabile. Lui stesso ne era conscio, tanto da dichiarare all’amico Martin Quast di sentirsi come imprigionato in un corpo che non rispondeva a ciò che la sua mente sapeva di dover fare. Come calciatore spaziò in diversi ruoli, dall’attacco alla difesa, dotandosi così della visione panoramica che di solito è appannaggio dei centrali di centrocampo, non a caso indicati, a torto o a ragione, come i più predisposti per un ruolo da allenatore. Sarebbe interessante tracciare il profilo, ammesso che ve ne sia uno coerente, del coach senza particolare talento da giocatore, provare a capire cioè quale superpotere si sviluppi in assenza di quella specifica predisposizione; volendo definire il talento, concetto assai effimero, lo si potrebbe racchiudere nella frase: “possedere una maggiore facilità naturale nel fare qualcosa” . Oppure, per dirla alla Flaubert, e quindi molto meglio, il talento è una lunga pazienza.
Non pago dei suoi impegni sul campo, si prestò a fare l’analista in tv, durante la Confederation Cup del 2005 e, in seguito, durante i mondiali tedeschi del 2006. Si badi che non stiamo ancora parlando dell’icona Klopp, ma del semplice allenatore di una squadra, il Mainz, che nel campionato 2003/’04 giocava in seconda divisione e che, da neopromossa in Bundesliga, aveva concluso il campionato 2004/’05 all’undicesimo posto in classifica. I dubbi tuttavia si dissolsero molto più rapidamente della nebbia di Belgrado e di Amsterdam, se è vero che persino il Kaiser, Franz Beckenbauer, rimase conquistato dalle analisi con il touchscreen, allo stesso tempo competenti e comprensibili. Anche Pelè, saltuariamente ospite in studio, trovò quel modo di comunicare, autentico e un po’ casual, come il look stesso di Klopp, qualcosa di divertente, da ammirare. Non furono della stessa idea gli osservatori mandati dall’Amburgo, interessati a valutare la persona e l’allenatore, ma riluttanti poi nel caldeggiare l’assunzione di un tipo che se ne andava in giro mal rasato e coi pantaloni bucati (e che, per giunta, tutti chiamavano Kloppo!). Alla fine fu proprio Kloppo a sbarrare la strada a ogni possibile trattativa: non gli andava che si dicesse che non si presentava puntuale agli allenamenti, perché non era vero.
Al di là del colore di qualche aneddoto divertente – e la carriera di Jürgen è una miniera, in questo senso – una cosa soprattutto resta dell’esperienza all’emittente Zdf: distante anni luce dal dibattito vacuo, volendo usare un elegante eufemismo, tra “giochisti” e “risultatisti”, l’allenatore tedesco rifuggiva, già ai suoi esordi, dal giogo del dogmatismo tattico, pur avendo sempre amato, come il suo maestro, Wolfgang Frank, come chiunque, vincere.
Jürgen Klopp, lo sappiamo, ha annunciato che a giugno lascerà il Liverpool e la Premier League. Sul futuro non è dato sapere, salvo che pare che lo svevo voglia prendersi almeno un periodo sabbatico, per ricaricarsi dalle fatiche degli ultimi anni. Ciò che ha detto con chiarezza è che non allenerà mai più in Inghilterra: non si senta a comprenderne la ragione. Se non fosse stato per la moglie, avrebbe abbandonato Anfield e il suo calore – che per gli avversari è assimilabile a quello dell’inferno! – alla fine della scorsa stagione, difficoltosa e recuperata in extremis con un onorevole quinto posto e con la qualificazione all’Europa League che si giocano da assoluti favoriti. Pep Guardiola, che con Klopp ha un rapporto che mi sembra ormai travalicare il semplice rispetto reciproco o la stima tra colleghi, ha detto: “he will be back”. Tornerà.
E noi ce lo auguriamo, ché in un calcio dai ritmi folli e sempre più egoriferito, abbiamo davvero tanto bisogno della calviniana leggerezza e della sagace ironia del nostro the normal one.

BIO Ilaria Mainardi: Nasco e risiedo a Pisa anche se, per viaggi mentali, mi sento cosmopolita.
- Sono titolare della pagina Instagram: ilarie.ed.eventuali
- Mi nutro da sempre di calcio, grande passione di origine paterna, e di cinema.
- Ho pubblicato alcuni volumi di narrativa, anche per bambini, e saggistica. Gli ultimi lavori, in ordine di tempo, sono il romanzo distopico La gestazione degli elefanti, per Les Flaneurs Edizioni, e Milù, la gallina blu, per PubMe – Gli scrittori della porta accanto.
- Un sogno (anzi due)? Vincere la Palma d’oro a Cannes per un film sceneggiato a quattro mani con Quentin Tarantino e una chiacchierata con Pep Guardiola!